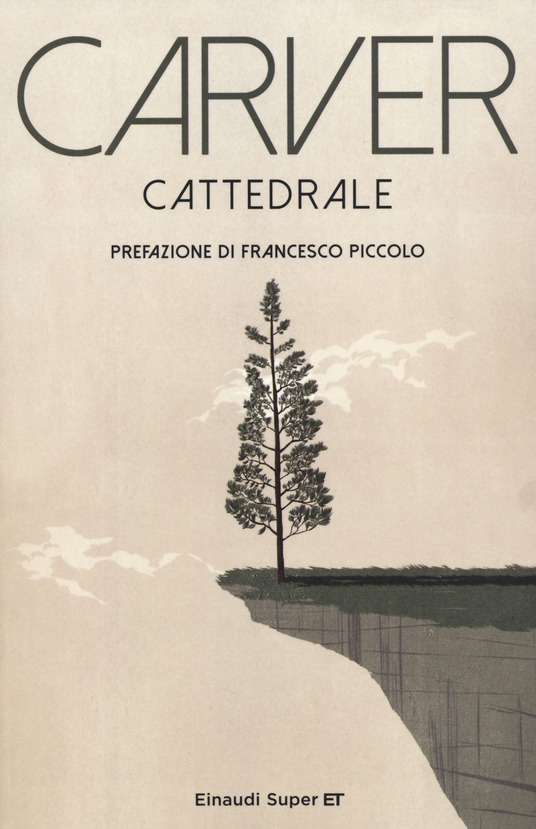“Ragioni per vivere. Tutti i racconti” di Amy Hempel.
“Ragioni per vivere. Tutti i racconti” di Amy Hempel.
Amy Hempel fa parte di quel gruppo di scrittori statunitensi che negli anni ’80 riportò in auge la forma racconto. Li accomuna – a grandi linee – la capacità di sfrondare la narrazione fino a una sintesi vigorosa, motore di situazioni e immagini sul confine del paradosso.
Dovendo identificare una figura che tiene assieme questo milieu letterario, viene naturale nominare l’editor Gordon Lish, patrocinatore e ispiratore di uno stile che fece scuola e che accomunò scrittori come Raymond Carver, Susan Minot e Jay McInerney.
Anche Amy Hempel, ovviamente, è immersa in questa corrente stilistica (Gordon Lish è stato un suo mentore), fatta di descrizioni fulminee, definitive, e di personaggi colti in situazioni emotive complicate; eppure, all’interno di una tendenza più o meno assodata, la scrittrice di Chicago trova modo di inserire una propria voce poetica, del tutto inconfondibile.
Una sorta di vitalità immateriale impreziosisce i suoi racconti, li rende rappresentazione di un’umanità in cerca di riscatto, che reagisce alle sconfitte e alle perdite sfoderando risorse inimmaginabili.
“Il mio cuore – credevo si fermasse. Così ho preso la macchina e sono andata a cercare Dio. Ho superato due chiese con qualche auto parcheggiata davanti. Mi sono fermata alla terza perché non c’era nessuno. Era pomeriggio presto, a metà settimana. Ho scelto una panca nella fila centrale. Episcopale o metodista, non aveva importanza. Era silenziosa come una chiesa. Ho pensato a quel battito mancato, e ai successivi che si precipitavano a colmare il vuoto. Sono rimasta seduta – nel sublime abbraccio del silenzio e dei vetri istoriati – e ho ascoltato.”
Dalla routine, a partire da relazioni che s’attorcigliano su se stesse, una forma di destino comune fa scaturire il battito sostanziale, la frase risolutiva, e questo processo trasformativo, di identificazione, fa venire in mente i racconti curvilinei e cangianti di Alice Munro.
 “John Cheever – I racconti” di John Cheever.
“John Cheever – I racconti” di John Cheever.
Imperdibile l’antologia pubblicata da Feltrinelli, che nella sua completezza dà conto della profondità e dell’acume di uno dei maestri riconosciuti del 900 americano.
Parliamo di un libro seminale, rivelatore, che all’epoca della sua uscita si aggiudicò il Premio Pulitzer e il National Book Critics Circle Award, nel 1979, e il National Book Award nel 1981.
John Cheever (1912 – 1982) è stato la cartina tornasole degli umori e dei tormenti della media borghesia statunitense, ne ha sviscerato gli eccessi – segreti o plateali – con una lucidità periscopica e implacabile.
Dopo di lui, dopo i suoi racconti in cui tragedia e commedia si mescolano dando vita a cocktails equilibratissimi, il benessere, l’approvazione sociale, l’American Dream, si tingono di una sfumatura cupa, che si insinua e lascia intravedere, in controluce, l’ossatura di ambizioni e relazioni borderline.
Dalle sue residenze suburbane, signorili, Cheever mette in scena l’Occidente pulsionale, dirompente nel bene e nel male, in cui i sentimenti tracciano linee discontinue, dall’indulgenza fino alla manifestazione delle umane debolezze. Il più e il meno dentro una contabilità da revisionare giornalmente, fino alla caduta improvvisa, che non tiene conto delle acquisizioni, di una prosperità placcata oro.
La trama diventa per Cheever un mezzo per comunicare un significato altro, come il lento incubo in cui sprofonda il protagonista del suo racconto più celebre, “Il nuotatore”, che dopo una festa in piscina da amici cerca di tornare a casa passando per le piscine delle proprietà che separano le due dimore.
“Gli sembrava di vedere, con un occhio da cartografo, quella catena di piscine, quel corso d’acqua quasi sotterraneo che si snodava attraverso la contea. Aveva fatto una scoperta, aveva dato un contributo alla geografia moderna, e quel corso d’acqua l’avrebbe chi amato Lucinda, col nome di sua moglie. Non era uno che amava particolarmente gli scherzi, né era un buffone, ma era volutamente originale, e si considerava in generale, e modestamente, un personaggio leggendario. Era una bella giornata, e gli sembrava che una lunga nuotata ne avrebbe esaltato la bellezza. Si tolse il golf che teneva sulle spalle e si tuffò in acqua.”
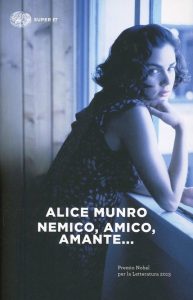 “Nemico, amico, amante…” di Alice Munro.
“Nemico, amico, amante…” di Alice Munro.
Premio Nobel nel 2013, Alice Munro è prima di tutto una maestra di stile: la sua scrittura asseconda un respiro inconfondibile, pacato e allo stesso tempo vibrante, in cui l’intero spettro delle conquiste e delle vicissitudini umane trova un’ideale collocazione.
Se in Cheever la scivolosità degli incontri, delle affermazioni di principio, si intrecciano in una omogenea intelaiatura di supporto, nella scrittrice canadese gli stessi impulsi ideativi funzionano da sottofondo, da sfumatura di una più sfaccettata struttura narrativa.
I racconti di Alice Munro prendono corpo e deviano in molteplici rivoli, si argomentano strada facendo, propongono asperità e dolci declivi, fino a una situazione, a un equivoco o a un gesto che irradia bagliori, consapevolezza del limite.
“Da allora, si era tagliata i capelli, li aveva decolorati e li portava corti e a ciocche ispide, e aveva anche perso parecchi chili. Si faceva chiamare con il suo secondo nome, adesso: Fleur. Non solo: l’impiego che le avevano trovato era in una cittadina a una discreta distanza da dove viveva allora. Era la terza volta che faceva quel viaggio. Le prime due, lui si era rifiutato di incontrarla. Se l’avesse fatto di nuovo, avrebbe smesso di provarci. E se anche avesse accettato di vederla, probabilmente non sarebbe tornata per un po’. Non voleva esagerare. A essere sinceri, non sapeva bene cosa avrebbe fatto.”
Nella splendida raccolta “Nemico, amico, amante…” gli affetti, che eventualmente sfociano in relazione amorose o in dolenti messe alla prova, accarezzano il quotidiano per poi svelarne l’essenza problematica, la sconfortante ambiguità. Munro assegna ai nove racconti dell’antologia il compito di smuovere, di sorprendere il lettore con una tattica di accerchiamento. Una donna malata di cancro che asseconda il piacere della seduzione, gli appuntamenti mancati dell’amore e lo sperimentarsi come coppia nonostante la malattia, le fantasmagorie della memoria: da una provincia uguale a mille altre il talento della scrittrice canadese estrae la nobiltà della vita, tenendosi lontanissima dal clamore delle messe in scena, delle formule adattabili al contesto.
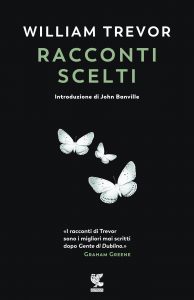 “William Trevor – Racconti scelti” di William Trevor.
“William Trevor – Racconti scelti” di William Trevor.
Narratore e drammaturgo, quattro volte finalista al Booker Prize e vincitore del premio Internazionale Nonino, William Trevor (1928 – 2016) ha scritto racconti memorabili, ma anche romanzi densi e introspettivi, come “Il viaggio di Felicia”, “La storia di Lucy Gault” e “Leggendo Turgenev”.
Il filo rosso che attraversa la narrativa di William Trevor è rappresentato dalla capacità di rendere i suoi protagonisti tridimensionali, strumenti di una possibile immedesimazione o di un turbamento. Nei suoi racconti i fatti, il terreno di coltura che accoglie ambientazioni e personaggi, rispondono a coordinate ben precise, a un sistema che integra tradizioni, ceti sociali, tipologie caratteriali, eppure il tutto (nei romanzi come nella narrativa breve) è sottoposto all’agente silenzioso, alle forze invisibili che aprono fenditure e delineano orizzonti alternativi.
Uomini silenziosi, all’apparenza inscalfibili, donne che architettano vie d’uscita da una quotidianità opprimente, e poi personalità sospese, sull’orlo di una mutazione, o di uno straziante addio alla vita.
L’Irlanda tratteggiata nelle piccole comunità, nei granitici nuclei familiari, negli ordinati pub, negli spacci alimentari e nelle sperdute canoniche dell’entroterra: la scelta del paesaggio, dei luoghi e delle stagioni, perfino degli arredi e degli indumenti, dà il senso di un microcosmo inviolabile, in cui le trame rimangono sotterranee, brulicanti a un centimetro dalla superficie.
Se non bastassero la scrittura equilibrata, di quell’equilibrio capace di integrare i meccanismi psicologici e culturali, e la fluidità di una prosa di impronta classica, musicale, questa sapienza amorevole nel descrivere l’Irlanda rurale e le sue inclinazioni va tenuta presente come valore assoluto, riscontro sociale e antropologico.
Il mistero nella semplicità, nei pensieri di esistenze ordinarie, in attesa di una luce trasversale, che segnala lo smottamento epifanico: leggendo William Trevor il pensiero va alle tematiche e al senso del trascendente di scrittori impareggiabili come Flannery O’Connor e James Joyce.
 “Cattedrale” di Raymond Carver.
“Cattedrale” di Raymond Carver.
“Erano diventati buoni amici, mia moglie e il cieco. Come faccio a sapere queste cose? Me le ha dette lei. E mi ha anche detto un’altra cosa. L’ultimo giorno di lavoro, il cieco le aveva chiesto se poteva toccarle il viso. Lei gli aveva detto di sì. Mi ha raccontato che lui l’aveva sfiorata con le dita dappertutto: il viso, il naso… perfino il collo! Lei non se l’era più scordato. Aveva addirittura cercato di scriverci su una poesia. Era sempre lì a cercare di scrivere una poesia, lei. Ne scriveva una o due all’anno, di solito subito dopo che le era successo qualcosa di molto importante.”
Più che i temi è la scrittura a caratterizzare l’opera di Raymond Carver (1938 – 1988). Scarna, fa pensare a una rotta nautica prevedibile, in un pomeriggio di bonaccia. Ma in agguato c’è la smorfia, il gesto istintivo che mette a repentaglio carriere, matrimoni, rapporti genitori-figli. Un baco erode progetti di vita e scampagnate, è il manifestarsi della frustrazione, della rabbia, di risposte non date o ignorate per troppo tempo. La crisi schiera le sue truppe dentro camere ammobiliate, cottage al centro del nulla, luoghi anonimi, e nonostante i colpi di mortaio dalle linee nemiche il confronto scoperchia devozione, sentimenti sottaciuti, tenere condivisioni.
Ritornando alla scrittura, allo stile di Raymond Carver, è inevitabile sottolineare come i suoi toni, la linearità, la laconicità dei dialoghi, abbiano prodotto innumerevoli tentativi di imitazione, ispirati, per l’appunto, da un’apparente (seppur chirurgica) trascuratezza formale. Ma è occultato nella bruma evanescente lo spirito, vale a dire l’individualità dello scrittore statunitense, il cuore e l’afflato poetico che lo rendono unico, un assoluto maestro delle short stories.
 “Racconti di Pietroburgo” di Nikolaj Gogol’.
“Racconti di Pietroburgo” di Nikolaj Gogol’.
Ancora i racconti di Nikolaj Gogol’ (1809 – 1852) ci sorprendono per la loro levità, implacabile come un’aria d’opera, e nella San Pietroburgo di metà 800 si muovono personaggi esemplari, ingranaggi dentro una dimensione che è impossibile non far coincidere con la parola destino.
“Se vi interessano le idee, i fatti, i messaggi, state lontani da Gogol’” dice Vladimir Nabokov, svelando suo malgrado il segno distintivo di un’opera che si allunga oltre gli orizzonti temporali, perché si azzarda a scardinare il visibile, l’inappuntabile, un ordine delle cose solo in apparenza assodato.
La raccolta, che venne data alle stampe dopo la morte dello scrittore di origine ucraina, mette assieme tre racconti pubblicati nel 1835 (La Prospettiva Nevskij, Le memorie di un pazzo e Il ritratto) e due immediatamente successivi: Il naso e Il cappotto.
Il ritratto impietoso di una città, di una sua direttrice simbolo, il Nevskij Prospekt, un cammino di follia dove la reclusione in una fantomatica corte spagnola è l’approdo ideale, lo specchiarsi in un dipinto che ha il potere di prosciugare l’anima di lo osserva, un naso che se ne va a zonzo per la città, prendendosi gioco del suo legittimo proprietario, l’orizzonte di sé in un cappotto elegante, perdita, conquista e di nuovo perdita di una riconoscibilità sociale: i singoli protagonisti delle storie allucinate e beffarde dei Racconti di Pietroburgo sono come uccelli migratori dispersi in una rotta circolare, costretti a stare al gioco nonostante le proprie ambizioni, le scrupolose (e perentorie) indicazioni di volo.
Grazie alla scrittura, straordinariamente elegante, e la predisposizione per il fantastico, il carattere narrativo di Gogol’ si fa vita, visionaria e concreta più che mai; una saldatura, un’interpretazione del mondo reale e magica che ancora oggi ci fa sorridere, amaramente, e ci suggerisce di proteggere fino allo stremo la nostra più intima fragilità.