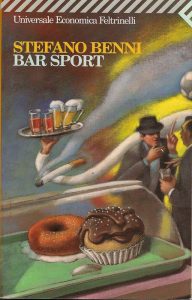Nel tentativo di individuare punti di riferimento nello sconfinato orizzonte della narrativa umoristica si rischia di inciampare nell’argomentazione, nel tentativo di aggiungere interpretazioni e dosi di profondità. Le ragioni dell’ironia, il balzo cognitivo che scatena l’ilarità, che accompagna il sorriso, sono materiale scandagliato a dovere in più e più occasioni, e lasciano in sospeso le intermittenze dello stupore, di un volteggio senza capo né coda. Quindi, a seguire, autori eccellenti e il loro stile, unico, indifferente alle elaborazioni a posteriori e poco incline alle manipolazioni altrui: si parte dall’originalità per colpire dritto al bersaglio, che sia questo il sorrisino complice, lo sghignazzo perfido o l’inatteso accendersi di una verità.
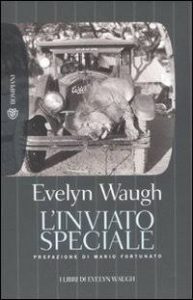 “L’inviato speciale” di Evelyn Waugh
“L’inviato speciale” di Evelyn Waugh
La penna di Evelyn Waugh (1903 – 1966) incide le pratiche del giornalismo d’assalto, e non conta che “L’inviato speciale” sia stato pubblicato negli anni 30 del novecento.
Improponibile il confronto fra tecniche e supporti così distanti nel tempo: eppure il protagonista del romanzo, uno spaesato giornalista marchiato dal pressapochismo, potrebbe tranquillamente ricalcare le gesta di un odierno cacciatore di scoop.
Si chiama William Boot, l’eroe per caso dell’affilatissimo e salace romanzo di uno dei maggiori umoristi del secolo scorso, un protagonista “sbagliato” perché in uno staterello africano per raccontare un possibile cataclisma politico si sarebbe dovuto recare John Boot, lui sì efficiente e in rampa di lancio verso il firmamento del giornalismo anglosassone.
Da uno scambio di persona il racconto assume su di sé vizi e frustrazioni di un mondo contraffatto, generatosi dal bisogno di apparire, di vendere anche soltanto una copia in più della concorrenza. La battaglia è feroce, e viene combattuta in spregio alla deontologia professionale: gli inviati nella tropicale Ismaelia (nome anch’esso fittizio) tracciano le nuove coordinate della verità e sarà proprio nella dimensione dell’insensatezza che lo sprovveduto William Boot giungerà a individuare il filo nascosto che conduce alla verità vera.
Da inetto a principe della notizia, perché l’inadeguato reporter sarà il primo a documentare un colpo di stato in itinere, naturalmente senza comprenderne le dinamiche e i possibili esiti finali.
Il giornalismo è stato più volte materia di dissacrazione da parte di Evelyn Waugh, che raccomandava ai suoi giovani colleghi di allontanarsene al più presto una volta raggiunto lo status di scrittori; ma al di fuori del contesto il consiglio può anche essere letto come una perorazione della profondità, dell’osservazione come albero motore dello sberleffo.
 “Un pezzo da galera” di Kurt Vonnegut
“Un pezzo da galera” di Kurt Vonnegut
Elemento cardine della narrativa di Kurt Vonnugut (1922 – 2007) è l’ibridazione, dove la creatività procede a briglie sciolte incontrando lungo il cammino scampoli di vita, passioni e curiosità intellettuali.
Se poi proviamo a far emergere un contenitore, un’approssimazione di genere, scaturirà dalla sua traiettoria letteraria la fantascienza, un indefesso lavorio per addivenire a un segno originale e rivelatore.
Vonnegut vaticinava il presente e i suoi rivoli sotterranei, alimentava le cronache future con il passato, le sue sue esperienze di soldato nella seconda guerra mondiale, ad esempio, e i modi rusticani con cui chiedeva spazio alla vita.
I registri si accavallano, rincorrendosi, dalla satira al motteggio elegiaco, dal comico al tragicomico e al dramma, e le sfaldature dei sistemi di dominio si rivelano sotto le lenti del paradosso e del libero arbitrio.
Nel protagonista di “Un pezzo da galera”, romanzo pubblicato nel 1979, è facile individuare una tradizione, un modello di sapiens che oltrepassa le barriere dello spazio-tempo.
Walter F. Starbuck è un “uomo di Harvard”, che inizia a farsi le ossa denunciando alcuni suoi amici alla famigerata Commissione McCarthy. La minaccia comunista attiva una contraerea che spara a sventaglio: tra le sue fila si fa notare un futuro presidenti degli Stati Uniti d’America, Richard Nixon, che avrà modo di indirizzare – con la sola forza delle sue virtù confessionali – il destino e la carriera di Walter F. Starbuck, dapprima oscuro burocrate in uno scantinato della Casa Bianca, poi utile idiota quando deflagrerà il caso Watergate e il comandante in campo gli affiderà in maniera subdola le casse con i nastri registrati che decreteranno la fine del mandato presidenziale.
Si direbbe l’ennesimo caso di capro espiatorio, se non che il burattino senza fili Starbuck, scontata una pena esemplare in un’elegante galera newyorchese, avrà modo di riabilitarsi assumendo un incarico di vertice in un imponente trust di compagnie americane.
Parabola di un company man, di un fante nella trincea del potere: Vonnegut in “Un pezzo da galera” sfodera le armi del sarcasmo per impallinare le infelici vanità, innescando, in parallelo, la sua mirabolante verve oratoria.
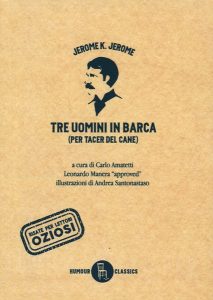 Tre uomini in barca (per non parlare del cane) di Jerome K. Jerome
Tre uomini in barca (per non parlare del cane) di Jerome K. Jerome
Tre uomini in barca (per non parlare del cane) di Jerome K. Jerome (1859 – 1927) è un classico della narrativa umoristica, e in quanto tale attraversa epoche e generazioni rinnovandosi nel semplice atto della lettura, del godimento che ne deriva.
Potrebbe essere anche la sobrietà un fattore che ha contribuito a rendere il libro dello scrittore e giornalista inglese un long seller planetario; non occorrono artifici, trappole stilistiche o allusioni per raccontare di una gita in barca sul Tamigi, e quando il sense of humor si nutre di quotidianità (non sempre idilliaca) la narrazione ne trae pieno giovamento, tocca corde ancestrali e profonde.
I tre uomini in barca sono Jerome (voce narrante), Harris e George, ai quali si aggiunge il fox-terrier Montmorency, tipico esemplare di quadrupede a cui manca solo la parola. Nell’attraversare la campagna inglese, in controcorrente, i gitanti si scambiano aneddoti e facezie, fanno fronte a imprevisti e filosofeggiano con irresistibile disincanto. Nel guscio di legno galleggiante custodiscono ognuno i propri difetti e attitudini, che vanno dall’ipocondria alla pigrizia e al piglio organizzativo.
Umorismo inglese, naturalmente, condito da una sorta di elogio dell’intraprendenza, che riverbera nell’immaginario del lettore; ed è proprio questa componente “avventurosa” ad allargare il bacino di utenza dell’opera, godibile dai fatidici 0 ai 99 anni di età, nelle innumerevoli e cangianti versioni editoriali (sfiziosa quella proposta nel 2020 da Sagoma, con illustrazioni di Andrea Santonastaso e prefazione di Leonardo Manera).
Sono trascorsi oltre 130 anni dalla prima uscita di “Tre uomini in barca (per non parlar del cane)”, misura mastodontica per un’opera “leggera”, nata, come spesso accade nelle opere immortali, da un equivoco, da un aggiustamento di prospettiva: in principio Jerome K. Jerome avrebbe dovuto realizzare una guida turistica dedicata al Tamigi, progetto che in seguito venne sfrondato dalle troppe digressioni e annotazioni storiche, lavoro di revisione sollecitato da un editore lungimirante che in tal modo trasformò una convenzionale guida del territorio in uno dei capisaldi della narrativa umoristica.
Riletto a più di quarant’anni dalla sua pubblicazione “Bar Sport” di Stefano Benni produce l’effetto di un ritorno al futuro: per chi ha vissuto da protagonista (o da comparsa) l’epopea dei bar sport come minestrone sociologico, o per chi, per ragioni anagrafiche, non ha potuto addentrarsi in quei luoghi di ritrovo sparsi a macchia d’olio nel territorio fino agli albori degli anni ottanta, il sentimento suscitato dalle figure tipiche e dalle suppellettili deificate dallo scrittore emiliano è di stupore, ma uno stupore da cavalcare nell’attesa di un risveglio, di una ricomposizione temporale.
Stefano Benni scrisse “Bar Sport” a 26 anni, e non fatichiamo a immaginarlo, più o meno a quell’età, seduto in un bar un tantino periferico ma vivacissimo a catalogare sguardi, dialoghi e fissazioni comuni; il suo intuito lo guida, e anche una predisposizione naturale per i tempi comici, per l’iperbole, per l’avventura ideativa che nelle sue opere successive troverà pieno e forse più strutturato compimento.
I bei tempi andati, in “Bar Sport”, sono personificati dal flipper, che a un occhio contemporaneo potrebbe apparire come un fossile venusiano, dal telefono a gettoni, soppiantato dagli odierni devices ad alto funzionamento, dal playboy di paese, ingentilitosi oramai a causa delle vanità social, dal visionario raccontatore di frottole e da decine di altri figuranti ed espressioni antropologiche a cavallo fra mito e gioiellino vintage.
In ventisette capitoli si snoda una visione calibratissima ed esilarante di un’Italia a metà del guado: nella provincia resistono sacche di umanità, tracce di un paese composito, in equilibrio su vecchie fondamenta, mentre nei centri urbani si dipanano gli anni di piombo, l’attesa per un ripristino delle nicchie sociali che condurrà all’individualismo, all’epoca dei cittadini-consumatori.
Amaro e divertente constatare come la commedia umana allestita da Stefano Benni (con al centro la “Luisona”, pasta leggendaria in bella vista nella vetrinetta sopra il bancone) corrisponda a una fuga allucinatoria, realizzi la metamorfosi dal genere comico-bozzettistico al fantasy. E per chi sostiene che “Bar Sport” senta addosso il peso degli anni, questa rielaborazione a posteriori potrebbe risultare persuasiva e persino seducente.
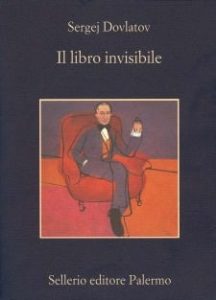 “Il libro invisibile” di Sergej Dovlatov
“Il libro invisibile” di Sergej Dovlatov
Tuttalpiù un irregolare, una voce fuoricampo che descrive piuttosto che formulare; ostico confrontarsi con i maestri e rimanerne a distanza di sicurezza: qua e là una spruzzata di Gogol’, di Bulgakov, le capriole e i paradossi del siderale Kafka.
Nell’arguzia che denuda il proprio vissuto sta la grandezza di Sergej Dovlatov (1941 – 1990), che dalla sua piattaforma di osservazione mira al bersaglio grosso delle debolezze umane.
Un irregolare a prescindere dal suo percorso letterario, per il resto tortuoso e zigzagante; Dovlatov nasce in una famiglia di gente di spettacolo, si concede la grazia di una giovinezza sregolata – da reporter verrà più e più volte messo in guardia e licenziato – fino a quando, verso la fine degli anni 70, non espatria negli Stati Uniti d’America, con il patentino di scrittore russo mai pubblicato.
Esterno ai condizionamenti, ispirato da un altrettanto grottesca giostra degli umani, compone negli U.S.A. quella che è stata definita la sua «commedia autobiografica», calvario di un intellettuale riluttante in cerca di visibilità nel mondo storto del regime comunista.
«L’inettitudine totale non era spendibile. Il talento era sospetto. La genialità terrorizzava. La moneta più gradita era una moderata competenza letteraria»: è l’apoteosi del tragicomico, dell’annaspare per conformarsi senza svendere anima e dignità letteraria.
Dalla piattaforma americana Dovlatov recupera situazioni surreali e i molteplici caratteri dell’unicum sovietico, con “Il libro invisibile” realizza miniature di cittadini abbagliati dal dogma di Stato, che nel quotidiano, nelle relazioni, si converte in malignità spicciola, scaltrezza e gusto per la sopravvivenza.
Riso amaro, a tratti liberatorio, che trova naturali corrispondenze nell’oggi, nelle controfigure universali, a meno che non si assuma come personale stella polare la coerenza, la facoltà di giudicare e la disponibilità ad essere giudicati.
Nel panorama contemporaneo si avverte la mancanza di scrittori linearmente sarcastici, e viene spontaneo considerare come l’esilio newyorchese di Sergej Dovlatov, purtroppo, sia durato poco più di una decade, interrotto dalla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1990 a nemmeno cinquant’anni.